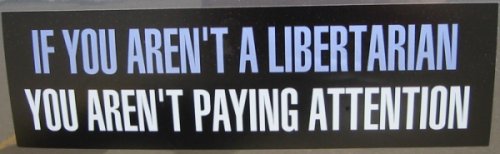martedì, marzo 13, 2012
Chi la fa l'aspetti: le regioni spagnole si ribellano al patto di stabilità?
Posted by J.C. Falkenberg at 9:46 PM |
Labels: Debito , enti locali , Spagna
lunedì, marzo 12, 2012
Spagna, il debito pubblico nascosto
E' ormai acclarato come la Spagna abbia un serissimo problema di peggioramento delle finanze pubbliche. Mentre l'Italia ha un alto debito statale, eredità di un passato di spese sconsiderate, la Spagna parte da una situazione migliore ma in rapidissimo peggioramento. I dati riportati dal Financial Times rivelano come in realtà la situazione sia ancora più problematica di quanto le statistiche ufficiali rivelino.
La misura standard impiegata per il conteggio del debito spagnolo esclude infatti i debiti derivanti da fatture scadute e non ancora pagate. SI tratta di più di 90 miliardi di debito, riconosciuti quale debito ma non inclusi nelle statistiche ufficiali: 30 miliardi di fatture non pagate per gli enti locali equivalenti ai comuni italiani; 18 miliardi per i governi regionali; 12 miliardi di fatture sanitarie non pagate ed infine 32 miliardi di "altri debiti" della stessa natura
La somma equivale a circa il 8.7% del PIL spagnolo del 2010. In Italia il dato equivalente per l'intero settore pubblico, è di 80 miliardi, ossia meno meno del 5% del PIL, pur includendo il governo centrale al contrario che per la statistica spagnola; è stabile o in calo ed è in parte incluso nelle statistiche ufficiali.
Un altro elemento preoccupante è quello dei tempi di pagamento, lievitati a 500 giorni ed ancora in salita - essenzialmente, molti enti semplicemente non pagano .
A questo si deve agigungere l'entità dei debiti del settore privato, molto più elevata che in Italia ed il fatto che la quota di tale debito finanziata all'estero è più elevata che quella italiana.
La crisi finanziaria degli ultimi anni ha reso familiari al grande pubblico concetti quali deficit, spread e l'importanza del rapporto fra debito e PIL. Quello che a volte si trascura è quanto accurate siano queste misure e quanto riflettano il vero fardello che stiamo lasciando in eredità ai nostri figli.
giovedì, gennaio 05, 2012
Valencia, o dell'altro buco nero spagnolo sommerso
Posted by J.C. Falkenberg at 12:41 PM |
Labels: Debito , Federalismo , Spagna
lunedì, gennaio 10, 2011
Portogallo, salvagente BCE
Secondo Reuters, la BCE starebbe comprando a man bassa debito portoghese, greco e irlandese, per stabilizzare la situazione. Se non siamo alla disperazione, poco ci manca. Il problema di queste tre nazioni, lo ripeteremo fino alla nausea, non è di temporanea assenza di liquidità, anche se Lisbona è la nazione si avvicina di più a questa definizione.
E' un problema di lungo periodo, di insolvenza: quella del governo greco, prigioniero di una politica vorace e di un pubblico drogato a colpi di panem et circenses elargiti a spese di una classe superiore più simile ad una plutocrazia preindustriale che ad una borghesia moderna. O del sistema bancario irlandese, colpevole di aver pervertito miracolo celtico, con la complicità di una politica monetaria eccessivamente lasca e di una regolamentazione criminogena e dannosa ancor prima che inutile.
Il Portogallo non è particolarmente sprecone, ma cresce troppo poco: è arrivato troppo tardi alllo sviluppo per poter imitare il miracolo economico tramite bassi salari, data la concorrenza asiatica ed ha ben poco a parte il turismo; rischia il fallimento per aver creduto al miraggio della bolla finanziaria, non per averne attivamente approfittato. Può evitarlo tramite austerità e, soprattutto, radicali riforme economiche liberali, le stesse che ha evitato quando ha cercato di ottenere i vantaggi dell'Unione, senza pagarne il costo (come molti, troppi altri stati europei).
Tutto questo poco importa, tuttavia, se verrà trasformato nell'ennesimo sistema economico-zombie dalla necessità della classe politica tedesca e francese di nascondere i propri errori e quelli dei propri protetti nelle banche statali delle due nazioni-guida.
Posted by Unknown at 5:02 PM |
Labels: crisi finanziaria , Debito , Grecia , irlanda , PIGS , Portogallo
CIna, il dilemma del creditore
Quanto conviene essere i maggiori creditori di qualcuno armato e pericoloso? I cinesi lo scopriranno a breve. Reuters) - President Barack Obama will host Chinese President Hu Jintao for a state visit on January 19, and the leaders of the two economic powerhouses are expected to discuss thorny issues such as China's trade surplus and its currency policies. The United States will tread carefully as Beijing is the country's largest creditor, holding more than $900 billion worth of U.S. Treasury bonds. Below are the top 10 largest holders of U.S. debt as of the end of October. -- China, mainland: $906.8 billion -- Japan: $877.4 billion -- United Kingdom: $477.6 billion* -- Oil exporters, which include Ecuador, Venezuela, Indonesia, Bahrain, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Algeria, Gabon, Libya, and Nigeria: $213.9 billion. -- Brazil: $177.6 billion -- Hong Kong: $139.2 billion -- Caribbean banking centers, which include Bahamas, Bermuda, Cayman Islands, Netherlands Antilles and Panama: $133.7 billion -- Russia: $131.6 billion -- Taiwan: $131.2 billion -- Canada: $125.2 billion
Factbox: China leads list of biggest U.S. creditors | Reuters:
giovedì, dicembre 02, 2010
Insolventi? Grecia, Irlanda, Portogallo, forse la Spagna.
Pensate che io sia eccessivamente pessimista? WIlem Buiter, ex blogger del FInancial Times appena assunto a Citigroup, è persino peggio.
Secondo Buiter, Irlanda e Portogallo sono già andati. La Grecia è in forse soltanto perché non è certo che il FMI e lA ue staccheranno la spina, faranno pagare il conto al resto dell'Eurozona (e qui concordo pienamente). La Spagna è in bilico sull0orlo del precipizio.
Le buone notizie? L'Italia dovrebbe essere al sicuro. Dovrebbe.
Personalmente, ritengo che l'intera Grecia e il sistema bancario irlandese siano ormai andati. Ogni euro prestato al governo ateniese e alle banche irlandesi serve a comprare tempo, ma non verrà quasi certamente restituito, a meno di trovare un altro pollo che presti denaro a banche e governi che hanno sprecato denaro e non hanno, n possono avere, i flussi di cassa per farcela. Accettare l'inevitabile e staccare la spina sarebbe più utile.
Al contrario, il governo irlandese ha dalla sua una nazione con una forza lavoro educata ed un'economia ancora flessibile e con del potenziale, nonostante i guasti causati dalla bolla immobiliare: la Tigre celtica, fino al 2002, era reale.
La Spagna potrebbe sopravvivere - a patto di buttare a mare la zavorra ed accettare la realtà: riforme e liberalizzazioni per aumentare le risorse in mano ai produttori di ricchezza e ristrutturazione del settore bancario delle Cajas.
Del Portogallo so troppo poco e quel poco mi preoccupa: poco flessibile, con poche industrie esportatrici, un'economia ancora rigida ed un settore finanziario opaco, una società orientata ad un corporativismo che offre pochi sbocchi.
Un'Italia in peggio, temo, anche se spero di sbagliarmi.
Hat tip:FT Alphaville
Posted by J.C. Falkenberg at 9:55 AM |
Labels: crisi finanziaria , Debito , irlanda , Mercati , PIGS , Portogallo , Spagna
mercoledì, dicembre 01, 2010
Nuovi piani europei per il debito: un salvagente americano per l'Europa e una pietra al collo per i produttori di entrambe le sponde dell'Atlantico
Giornata di ottimismo e recuperi per il debito dei paesi periferici europei. La scintilla è arrivata dalle voci di vari interventi e da un'ondata di acquisti da parte della BCE. Questi interventi rischiano di essere deleteri nel lungo periodo, ma nel breve hanno spezzato (a caro prezzo, se attuati) il circolo vizioso e hanno ala fine ottenuto un forte rialzo dell'euro, oltre a un rimbalzo feroce dei mercati.
Il piano di centralizzazione dell'emissione di debito nasconderebbe le debolezze dei paesi problematici dietro al copertura delle nazioni più forti, facendo pagare ai contribuenti francesi, olandesi e soprattutto tedeschi i vizi mediterranei e le intemperanze dei banchieri tedeschi in Irlanda e Grecia, ma risolleverebbe il mercato almeno nel breve periodo. E' uno schema analogo a quello che ha dato vita a Fannie Mae e Freddie Mac, garantite dal governo e in grado di sussidiare il mercato immobiliare americano senza pesare ufficialmente sui conti pubblici, salvo implodere in maniera spettacolare con perdite per centinaia di miliardi di dollari. Analogamente, pensiamo a quanto accade nelle Regioni italiane: il governo centrale s'indebita, poi gira le risorse raccolte alle regioni in deficit, coprendone i problemi e pagando interessi e capitale con il denaro prelevato nelle aree virtuose.
In teoria, il controllo centrale dovrebbe disciplinare gli enti viziosi. In pratica, vediamo quanto male questo funzioni in Italia: pensiamo davvero che funzionerebbe meglio questo sistema, se venisse gestito dall'euroburocrazia di Bruxelles?
martedì, settembre 07, 2010
Debito, un'immagine vale mille parole
sabato, giugno 26, 2010
Basta debito: come tutte le droghe, sta smettendo di funzionare
La ripresa sembra indebolirsi. Significa che la Fed dovrebbe ricominciare ad acquistare debito pubblico e privato, pompando liquidità e sostenendo i livelli attuali di debito e tassi? Da Annaly Capital Management ecco un'ottima sintesi dei motivi per cui sarebbe un errore devastante, simile a quello già compito dai giapponesi. Non soltanto si tratta di un'operazione dannosa nel lungo periodo, ma l'efficacia della droga debitoria diminuisce ad ogni successivo stimolo e quindi rischierebbe di risultare inutile anche nel breve termine.
(Hat tip: PragCap)
Some recent economic data (like today’s downwardly-revised “final” reading on 1Q 2010 GDP) have suggested that the economic recovery is waning. Not surprisingly, talk of additional stimulus has started to show up. A widely circulated column from today’s UK Telegraph titled “Ben Bernanke Needs Fresh Monetary Blitz as US Recovery Falters” theorizes that the Fed is debating further asset purchases. The rationale is that since there is reduced appetite for further fiscal stimulus, the Fed will pick up the baton and expand its balance sheet, possibly to $5 trillion.
Our modest proposal? Don’t.
The Fed should certainly do its part to facilitate the orderly functioning of financial markets, through the various lending facilities it has already set up (and in some cases shut down). But more asset purchases? What is the point? The 10-year Treasury is already approaching 3%, and corporate borrowing rates are more than reasonable on an absolute basis. 30-year fixed mortgage rates are already at brand new lows, and this is after the Fed concluded its Agency MBS purchase program.
There is an iron-clad law in economics called the law of diminishing marginal returns, which usually refers to labor. The more workers you continue to add, holding all other inputs constant, the less productive are those additional new workers. As we’ve already seen by looking at the money multiplier, the Fed’s balance sheet is also subject to diminishing marginal returns. The Fed’s expansion of the monetary base is having a smaller and smaller effect on the overall money supply. We believe further growth of the Fed’s balance sheet will have an even smaller effect than the first expansion, which seems to have only given us a ripping year-long rally in risk assets.
In the light of calls for new government stimulus, we should point out that the same law of diminishing marginal returns applies to total debt outstanding in the economy. As the total amount of debt to GDP has grown, the marginal return of an additional dollar of debt has shrunk dramatically. The chart below breaks out by decade the addition to GDP per each additional dollar of credit market debt outstanding.
To construct this chart, we looked at the nominal growth in GDP and divided it by the nominal growth in total credit market debt outstanding. As you can see, in the 1960s each additional dollar of debt created just over $0.65 of GDP. The 1980s saw this ratio cut in half to $0.34 dollars of marginal GDP per $1 of marginal debt, and we have since cut that in half again to $0.18 of GDP per $1 of debt created. We seem to be quickly approaching a level of total debt outstanding where additional indebtedness doesn’t add to economic growth at all. And the Fed has already reached a level in its Federal Funds Rate where it can’t cut any lower.
Attempts to stop a deleveraging economy with quantitative easing and government deficit spending have reached a point of no (marginal) return. Recessions, though painful, have the effect of purging the economy’s excesses and setting the stage for future growth. Preventing this process often causes more problems than it solves. Just ask the Japanese.
Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.
"Posted by J.C. Falkenberg at 3:43 PM |
Labels: crisi finanziaria , Debito , Economia , Fed
lunedì, novembre 30, 2009
CHi parla
Phastidio sintetizza in maniera interssante quanto sta avvenendo fra Dubai e la Grecia, oltre a dare un esempio di qualcosa che qui si sostiene da anni: per uscire dalla crisi è indispensabile apprendere di nuovo che il rischio esiste sempre, dove c'è rendimento - ed il rischio di fallimento e ristrutturazione c'è sempre. Cercare di azzerare il rischio tramite il binomio regolamentazione + bailout è una illusione statalista, destinata al fallimento; l'unico modo per disciplinare i banchieri è ripristinare la paura delle conseguenze di una decisione sbagliata.
Ogni alternativa è illusoria, vista la presenza di una fiorente industria specializzata nell'aggirare ogni regolamentazione, per quanto draconiana o bizantina, lasciando alle banche i soli vantaggi dei salvataggi. Per banchieri e speculatori, sarebbe invece impossibile evitare l'ira dei propri investitori, se le perdite derivanti dai propri errori venissero pagate in prima persona.
Non sarei così certo che Dopo Dubai i mercati parlano a Dublino affinché Roma intenda. O meglio, non credo che Roma sia la nazione più a rischio. L'Italia è in una sgradevole situazione debitoria, ma relativamente stabile. Al contrario di nazioni come Grecia e Spagna, il cui squilibri sono potenzialmente devastanti, oppure dei giganti anglosassoni, che stanno per scoprire i dolori dell'assenza di equilibrio fiscale.
martedì, agosto 25, 2009
Washington, continuiamo ad avere un problema
E' vero che non si sa mai per quanto tempo l'equilibrio fra paura ed avidità possa essere sostenuto a livelli irrazionali , prima di allinearsi , soprattutto quando un mercato viene distorto e drogato dall'intervento pubblico ed in questo caso, abbiamo
addirittura un duplice intervento di operatori al di fuori dei limiti del mercato. Da un lato, la Federal Reserve continua a mantenere tassi d'interesse vicini allo zero. Dall'altro, la Banca Centrale Cinese continua ad acquistare titoli di Stato, in parte come conseguenza della manipolazione del valore della propria moneta e in parte per sostenere le quotazioni dell'ingente posizione che detiene.
Karl Denninger. “I count $207 billion, coming two weeks after a $250 billion dollar week |
venerdì, agosto 14, 2009
Crosspost of the day : l'Avviso comune sul credito
Crosspost da Libertiamo.it
- L’accordo fra banche ed associazioni di categoria firmato pochi giorni fa potrebbe essere una buona notizia per le piccole e medie imprese italiane, se fosse applicato rapidamente ed in buona fede. Purtroppo, l’attenzione alla sostanza nel breve periodo lascia aperti due rischi sostanziali di medio e lungo periodo: che questo accordo venga pagato a caro prezzo dal contribuente e che si trasformi nell’ennesimo chiodo nella bara del futuro di una economia libera e prospera.
L’Avviso Comune siglato il 6 di agosto dall’ABI e da una serie di associazioni di categoria fornisce un quadro comune alle banche intenzionate ad estendere in maniera sistematica alla piccole e medie imprese in migliore salute gli strumenti d’intervento che sono molto comuni per le imprese grandi e medio-grandi, cioè il riscadenziamento del rimborso dei debiti per aziende solvibili, ma in temporanea illiquidità.
I requisiti necessari per accedere al programma sono rigorosi, ma non eccessivamente: l’azienda dev’essere stata un pagatore regolare sino al 30 settembre 2008, ossia all’inizio della fase più acuta della crisi. Non viene previsto un aumento delle linee di credito, ma soltanto una loro modifica, spesso vitale: per chi abbia contratto un mutuo od un contratto di leasing e sia in lieve ritardo sui pagamenti si apre la possibilità di posticipare il rimborso delle quote di capitale per un anno, pur continuando a pagare gli interessi sul debito; ancora più rilevante è l’automatica estensione delle anticipazioni su credito, che permette alle aziende con un portafoglio ordini e clienti solidi di poter ottenere il finanziamento del magazzino e del capitale circolante necessario per poter continuare la produzione di beni la cui vendita è spesso già certa.
Il punto saliente e di maggiore efficacia teorica del protocollo è il principio del silenzio-assenso, ossia l’automatismo nell’accesso al programma per le aziende che presentano i requisiti necessari, la cui domanda si riterrà automaticamente accettata trascorso un determinato periodo di tempo.
E’ questa la vera novità di tutto l’accordo e si tratta potenzialmente di uno sviluppo molto positivo nell’accesso al credito per le PMI.
Questi interventi vengono fatti quotidianamente per le aziende di dimensioni medio-grandi, anche se l’impressione è talvolta che le banche decidano con criteri estranei alle valutazioni di profittabilità. Anche la disponibilità a prestare nuovo credito in cambio di aumenti di capitale è parzialmente cosmetica, in quanto si tratta di una pratica assolutamente normale.
Le intenzioni dell’intervento tremontiano sono encomiabili, anche se il metodo è potenzialmente pericoloso. Il sistema bancario italiano è abituato a trattare le piccole e medie imprese in maniera amorfa, come un banco di sardine a cui riservare indiscriminatamente lo stesso trattamento: finanziamenti a pioggia quando va bene, carestia per tutti quando le cose non girano. Poca flessibilità e soprattutto pochissima attenzione a discriminare fra aziende solide ed aziende improvvisate. La solidità patrimoniale è infatti il segnale di un luminoso passato che potrebbe essere dietro le spalle, laddove invece un’azienda nuova ed in forte crescita potrebbe aver bisogno di finanziamenti per un capitale circolante in crescita in ragione del proprio successo e non dei propri fallimenti.
L’accordo è, quindi, giustamente diretto a salvare la “crema” delle aziende italiane PMI ed in questo è diverso rispetto ai soliti programmi di aiuti a pioggia. Mette inoltre sotto pressione le burocrazie bancarie nel proprio punto più debole, la lentezza di risposta verso le imprese non “amiche” e favorite, spingendole in teoria ad un aumento dell’efficienza nella propria attività caratteristica. Il problema fondamentale dell’accordo risiede nel carattere dirigista della sua gestazione e nella scarsa chiarezza del rapporto fra governo e banche. Rimane innanzitutto da capire cosa ci guadagnano le banche dall’adesione a tale protocollo, per il momento pienamente opzionale. Il ministero non ha ancora promesso nulla, ma si profila uno scambio di favori a spese della fiscalità generale, come ha dichiarato lo stesso Tremonti:
“Dal funzionamento dell’accordo dipenderà la decisione del governo di rivedere il meccanismo fiscale delle perdite delle banche,[...]. Se l’accordo funzionerà il governo modificherà il meccanismo fiscale delle perdite. Prima vediamo se l’accordo funziona poi faremo gli sgravi”.
Il primo rischio è quindi che le banche si permettano di accettare la moratoria per chiunque possieda i requisiti formali per accedervi, senza effettuare una sufficiente valutazione. Trascorsi alcuni mesi, il rimborso delle inevitabili perdite sarebbe oggetto di un mercato delle vacche con il Ministero, aggravando il problema procedurale.
Da un governo di centrodestra che si definisce liberale ci si aspetterebbe che non aumentasse l’interferenza statale nell’economia, procedendo inoltre per leggi ed interventi di carattere generale. Tale vincolo è stato rispettato soltanto parzialmente. Questo intervento è stato costruito e propagandato come un intervento quasi personale del ministro e del governo per trovare una soluzione ad hoc, un favore concesso dalle banche e che verrà ripagato con altri favori personali o quasi. Si rischia di dare quindi un terribile esempio: la necessità della continua interferenza governativa nella libertà economica, laddove invece si sarebbe potuto operare senza tale ipoteca, che rischia di compromettere ogni futuro sforzo liberalizzatore del governo verso una struttura economica più equilibrata, libera e di conseguenza efficiente.
Comprendiamo come le sue radici abbiano portato il ministro ad avere un approccio apparentemente pragmatico. Il sistema bancario moderno è un settore ad economia “mista” da sempre, il frutto di un patto faustiano che avvelena da generazioni l’economia di mercato. Il mercato monetario è un monopolio statale, dove la banca centrale decide quanta liquidità erogare e a quale prezzo; il settore bancario è un oligopolio sanzionato dalla classe burocratica e politica, anche dopo la fine della proprietà statale. I banchieri sono ovunque dirigenti ad autonomia limitata da politici e banchieri centrali, che hanno il diritto d’interferire nella gestione bancaria nei minimi dettagli e di ordinare distorsioni nell’allocazione del credito; in cambio, il management bancario ottiene la garanzia esplicita od implicita di un salvataggio e l’autorizzazione a trattare azionisti e clienti alla stregua di un parco buoi.
Dispiace che non si sia colta l’occasione per riformare il settore in senso liberale ed obbligarlo per una volta a camminare con le proprie gambe. Lo sforzo di incentivare comportamenti più razionali da parte degli istituti di credito è meritevole, ma invece di un intervento ad hoc sarebbe stato forse preferibile intervenire sui punti deboli del sistema che possono essere rafforzati senza aumentare l’intrusione della politica nelle banche. Vi sono norme presenti nei tanto vituperati accordi di Basilea 2 e nella recente normativa MiFid che non sono mai state applicate o sono state interpretate in maniera ristretta e favorevole ad equilibri collusivi, sia dal lato del trattamento riservato ai risparmiatori che a quello riservato alle aziende. La rimozione dei vincoli più anacronistici all’emissione di obbligazioni e di carta commerciale, ad esempio, permetterebbe alle aziende italiane di accedere più liberamente al mercato dei capitali, che in questi mesi ha dimostrato di saper fornire abbondante liquidità in alternativa al sistema bancario tradizionale. Soprattutto, una maggiore concorrenza stimolerebbe una maggiore attenzione verso il cliente, sia dal lato del risparmio che da quello dei prestiti. La tendenza all’entrata di banche estere sul mercato italiano ha già portato ad alcune novità, ma l’ostacolo più rilevante è di natura amministrativa: a fronte di una legge relativamente moderna, la prassi delle autorità di regolamentazione restringe drasticamente il campo d’azione per i nuovi operatori, riducendo gli incentivi a rompere l’oligopolio bancario. Inoltre, la politica delle banche italiane è stata troppo spesso quella di sfruttare le normative esistenti per frapporre limiti alle scelte disponibili ai risparmiatori ed ai clienti, boicottando ogni attività volta a responsabilizzare gli investitori. Leggi nate per difendere consumatori poco sofisticati hanno bloccato lo sviluppo del settore, senza per questo costituire una vera protezione per il risparmio o per le aziende. Questo eccesso normativo puramente formale, che garantisce una facile rendita di posizione al sistema bancario, non viene scalfito dai provvedimenti attuali.
Se con questo accordo volevamo normalizzare il settore bancario e lasciarlo finalmente funzionare come ogni altra industria in un’economia di mercato, siamo probabilmente sulla cattiva strada. Se vogliamo continuare ad impiegarlo come l’equivalente economico di un a squadraccia paramilitare, la soluzione italiana è migliore della sua versione USA, ma d’altro canto, abbiamo (tragici) decenni d’esperienza nel settore, al contrario degli americani, nuovi arrivati nel mondo del corporativismo. Non lamentiamoci però se gli italiani decideranno di votare per partiti onestamente socialisti, invece che per una loro imitazione, o se la belva ci sfugge di nuovo di mano: Frankestein, e la vicenda IRI, insegnano che certe creature hanno il brutto vizio di rivoltarsi contro il proprio padrone.
martedì, febbraio 03, 2009
Siamo tutti overleveraged
Un post di Aleph offre una prospettiva interessante sul motivo per cui questa recessione è così pesante e difficile da gestire: la bolla è stata globale, con differenti manifestazioni a seconda delle nazioni e dei settori. Posso aggiungere che rivela anche 'ipocrisia della retorica di certe nazioni esportatrici "virtuose" , che si sentono autorizzate a dare lezioni di moralità economiche ai "cattivi" anglosassoni: hanno partecipato tutti della crisi, ma la maggiore trasparenza delle economie finanziarizzate rende i sintomi più evidenti, senza che siano più severi altrove.
Le economie occidentali hanno accentuato tropo la leva finanziaria, ma quelle asiatiche hanno ecceduto nella leva operativa. Il risultato è che gil occidentali hanno troppi debiti, ma gli asiatici e le altre economie in crescita hanno un problema altrettanto grande: un eccesso di capacità produttiva, costruito per servire una domanda gonfiata da quello stesso debito che contribuivano a finanziare.
Hat tip:The Aleph Blog : Leverage Begets Leverage, and Vice-versa
mercoledì, luglio 25, 2007
Chrysler e Boots: macchine e creme, lacrime e sangue
L'acquisto di Chrysler verrà postposto e finanziato almeno in parte, pare metà, dalle banche che hanno sottoscritto i bridge loans e che non sono più riuscite a piazzare successivamente il debito agli investitori istituzionali, scaricando rischio e tenendosi le laute commissioni che vengono corrisposte per il lavoro - ed il rischio d'insuccesso.
Ancora peggio, è fresca la notizia su Alliance Boots. Il rivenditore di farmaci e cosmetici inglese è stato acquisito da KKR e dall'italiano Stefano Pessina in Aprile. L'acquisizione è stata finanziata da un consorzio di otto banche, guidato da Deutsche Bank e che include Unicredito e JPMorgan, che hanno anticipato i 5 miliardi di sterline di debito necessari in cambio del mandato al successivo collocamento. Anche dopo aver esteso la scadenza del collocamento e ritoccato i termini economici, il consorzio non è riuscito a piazzare l'intero ammontare, ma soltanto 1.75 miliardi di sterline di "junior loans" subordinati, che verranno oltretutto rivenduti in perdita, azzerando gli utili da commissioni generati dall'affare. Le banche dovranno inoltre tenere sui propri bilanci 3.75 miliardi di sterline di prestiti "senior", quelli meglio garantiti, che non sono stati in grado di piazzare.
In entrambi i casi, sembra che KKR e Cerberus abbiano risposto in maniera molto simile alle richieste d'aiuto delle banche: non se ne parla, abbiamo pagato commissioni esorbitanti per anni, è ora di guadagnarvi quei soldi.
Le acquisizioni che hanno generato tale debito sono già state finalizzate, quindi tale debito è di fatto già nel sistema finanziario e non può essere ripagato immediatamente, ma rimarrà nei bilanci delle banche d'affari in attesa di essere scaricato. Si alimenta così perversamente i timori di un "glut", di un ingorgo che peserà sul mercato nei mesi a venire, ritardandone la stabilizzazione.
Fonti: WSJ, TheDeal.com, Bloomberg, DealBook
tag: Leva, LBO, Mercati, Debito, Credit, KKR, Alliance Boots, Chrysler, Cerberus, Unicredito, Deutsche Bank, JPMorgan, Finanza,Economia
Posted by Unknown at 2:24 PM |
Labels: Alliance Boots , Cerberus , Chrysler , Credit , Debito , Deutsche Bank , Economia , Finanza , JPMorgan , KKR , LBO , Leva , Mercati , Unicredito