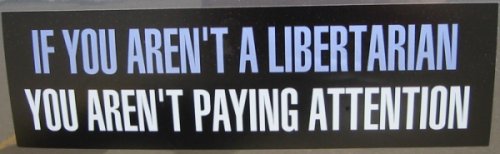domenica, marzo 11, 2012
Sul fiscal compact, Germania e Spagna errano simmetricamente
lunedì, gennaio 09, 2012
Santander e depositi: crepe in Spagna e Italia
Ricordate il vecchio film "L'aereo più pazzo del mondo"? Durante il disastro, una delle hostess continua a ripetere "niente panico" fino a quando, di fronte all'anarchia, cambia improvvisamente, ma senza perdere l'aplomb "Niente panico, niente panico... OK, panico".
Abbiao ora due elementi per preoccuparci dell'arrivo di un simile momento anche per due dei tre malati più grandi d'Europa: Italia e Spagna. La Francia, per ora, continua a rifugiarsi in ragionamenti sin troppo simili al mantra italiano del 2009-2010, ossia "noi ne usciremo meglio di altri", anche se a giudicare da alcuni dati microeconomici e dalle proposte demenziali di Sakrozy sulla Tobin Tax potremmo essere portati a dubitarne.
Cominciamo dai dati sui depositi in Italia e Spagna: i deflussi cominciano a diventare rilevanti anche in Italia, mentre rimangono a livelli elevati in Spagna. In due mesi il sistema bancario spagnolo ha perso 32 miliardi di depositi, quello italiano 37 miliardi in un mese; consigliamo al riguardo attenta lettura dell'ottimo Phastidio. A parziale consolazione, si potrebbe ipotizzare che una parte di depositi si siano indirizzati verso BOT e Bonos emetti dai relativi governi. Sarebbe una ben magra consolazione per le banche, cannibalizzate agli stessi governi per cui stanno svenandosi per sostenere i risultati della aste di titoli di Stato e arginare così la salita dei costi di finanziamento dei rispettivi governi.
Rimanendo in Spagna, è interessante la manovra effettuata da Santander per riuscire a raggiungere i livelli di capitale richiesti dall'EBA. La banca spagnola ha sempre sostenuto di non avere bisogno di effettuare manovre straordinarie, ma che avrebbe ridotto le proprie quote di maggioranza in alcune consociate estere o venduto alcune partecipazioni in mercati minori. L'operazione non dev'essere andata del tutto come previsto, visto che si è trovata costretta a parcheggiare in extremis presso un'anomia istituzione compiacente il 4.41% del capitale di uno dei gioielli della corona, la propria consociata brasiliana. La quota è al servizio di un prestito convertibile detenuto dal fondo sovrano del Qatar, che scambierà il bond con azioni al più tardi nel 2013. Di conseguenza il "parcheggiatore" non si assume quasi alcun rischio; ci si deve invece chiedere il perché di tanta fretta da parte di Santander, che pur avendo di fatto un compratore sicuro si trova costretto a pagare ampie commissioni per rendere spostare capitale da un cono del bilancio ad un altro solo per soddisfare l'autorità di regolamentazione. Evidentemente, la situazione non è tanto rosea e tranquilla quanto dichiarato dal gigante bancario. Sospettiamo che l'attività di acquirente di ultima istanza dei titoli di Stato spagnoli emessi alle ultime aste cominci ad assumere un certo peso nella gestione di una delle poche realtà multinazionali iberiche, anche perché il coinvolgimento di Santander è sempre più cruciale per il buon risultato delle aste: nelle ultime due occasioni, una banca rimasta anonima avrebbe acquistato gran parte dei Bonos offerti, garantendo un ottimo risultato nonostante i bassi rendimenti pagati dal Tesoro spagnolo rispetto a quelli prevalenti sul mercato al momento dell'emissione. Ci si dovrebbe chiedere, fra parentesi, per quanto tempo le autorità di vigilanza inglesi, brasiliane o americane guarderanno favorevolmente all'impiego di utili (o depositi) generati nei rispettivi mercati per sostenere il governo di Madrid.
Crossposted su Notapolitica
martedì, dicembre 20, 2011
Il mistero spagnolo?
Phastidio s'interroga sul mistero spagnolo : i mercati hanno reagito meglio alla manovra spagnola che a quella italiana, nonostante (aggiungo io) le prospettive iberiche sembrino più problematiche di quelle italiane.
martedì, settembre 27, 2011
downgrade bancari: l''ultimo dei problemi
La reazione istintiva è stata, per molti, quella di ricorrere alla teoria del complotto: le agenzie di rating hanno inferto, per oscuri scopi, una improvvisa pugnalata alle spalle alle banche. La vera tragedia è invece che le decisioni delle agenzie di rating sono solo l’ultimo dei problemi per i sistemi bancari di entrambe la nazioni, .
Dal punto di vista meramente tecnico, l’azione di declassamento delle banche italiane era soltanto questione di tempo. I rating di una banca non possono essere superiori, in linea generale, al rating della nazione nella quale ha sede; una volta declassato il merito di credito dell’Italia, il processo di revisione al ribasso si è messo in moto e non poteva avere conclusioni molto differenti. Intesa, Mediobanca e BNL non sono peggiori delle altre, ma al contrario erano fra le poche banche rimaste ad avere un merito di credito così alto da essere sensibili al “tetto” costituito dal rating della Repubblica Italiana. Le altre avevano già rating inferiori e quindi non sono state toccate.
Il declassamento delle tre grandi banche americane è fondamentalmente avvenuto per lo stesso motivo: Moody’s aveva inizialmente risparmiato loro un taglio di rating profondo quanto quello di altri giganti bancari come Goldman Sachs o JPMorgan, ritenendo che avessero unlivello di supporto governativo implicito superiore quello di queste ultime. Visti i recenti sviluppi politici, invece, l’agenzia ritiene ora che non vi siano più particolari differenze.
Perché questa importanza sul supporto statale per un settore economico particolare all’interno di un’economia di mercato che si proclama essere ormai libera, anzi troppo libera? Perché tale libertà dai diktat politici nella realtà non esiste, persino in Occidente, per ampi settori della vita economica. Le banche non sono aziende come la altre, ma vivono all’interno di un “patto col diavolo” che sospende almeno parzialmente il funzionamento del sistema di mercato: per cui da un lato sono sottoposte ad una vigilanza che decide aspetti essenziali della gestione; dall’altro, godono di una forte limitazione della concorrenza, di un accesso privilegiato alla BCE e della presunzione che, in caso di problemi seri, il governo interverrà salvando non soltanto i depositanti, ma tutti i creditori e forse anche gli azionisti. Le agenzie di rating tengono conto di tale situazione, come lo fa l’intero mercato, anche se raramente viene esplicitata chiaramente; laddove il credito del potere politico cala, così deve seguire quello dei propri protetti e si è semplicemente certificato ciò che era già reso evidente dal crollo delle quotazioni. Il problema, semmai, è il rilievo dato ad istituzioni che non sono più in grado di fornire nuove informazini od analisi pregnanti, anticipando i mercati. Le agenzie di rating si sono trasformate da istituti di ricerca a meri certificatori dell’ovvio, burocrazie operative con tempistiche talmente lunghe da arrivare regolarmente in ritardo, esattamente ad immagine delle burocrazie ministeriali che le hanno plasmate, trasformandole nel tempo in monopoli garantiti per legge e sottraendole alla disciplina della concorrenza. Fato comune, d’altronde, alle banche che dovrebbero analizzare.
Posted by Unknown at 9:25 AM |
Labels: Banche , Banche Centrali , Regolamentazione , Statalismo
venerdì, febbraio 11, 2011
Quanto Citigroup e Morgan Stanley Teetered sono state sulll'orlo del baratro nel 20080?
giovedì, novembre 18, 2010
Irlanda: la farsa continua
Posted by J.C. Falkenberg at 11:33 AM |
Labels: Banche , Banche Centrali , irlanda , unione europea
martedì, settembre 07, 2010
Stress test bacati, il segreto di Pulcinella
Posted by J.C. Falkenberg at 4:49 PM |
Labels: Banche , Collettivismo , Crisi , Mercati , Socialismo
mercoledì, aprile 21, 2010
Ma quale rIforma finanziaria USA
Posted by J.C. Falkenberg at 4:23 PM |
Labels: Banche , Obama , Regolamentazione
giovedì, gennaio 21, 2010
E questo lo chiamate capitalismo?
Morgan stanley paga il 62% delle proprie entrate in stipendi e bonus, mentre la banca affronta una perdita. IN un'azienda normale gli azionisti starebbero già chiedendo la testa del management. In una banca, questo non è possibile, vista l'acquiescenza del vero azionista di maggioranza: la banca centrale e le autorità di vigilanza, che controllano di fatto il processo di selezione ed approvazione del management, senza contare il prezzo e il quantitativo della materia prima per l'attività bancaria , ossia i tassi di interesse e la liquidità. Sentirete giustamente parlare dell'avidità dei banchieri e del capitalismo; non è invece colpa del "mercato": è colpa di chi impedisce agli azionisti, ossia al mercato, di correggere gli errori di coloro che vengono protetti da quegli stessi politici e burocrati che hanno bloccato e bloccano il corretto funzionamento del mercato, al quale attribuiscono però le conseguenze dei propri precedenti errori ; ricordatevelo, quando sentirete le proposte di correggere gil "eccessi" tramite maggiori regolamentazioni, ossia la stessa strada che ci ha già portato a questa crisi. Da quando ripetere gli stessi errori aiuta a risolverli?
Hat tip: DealBook Blog
Posted by J.C. Falkenberg at 10:20 AM |
Labels: Banche , capitalismo , Finanza , Morgan Stanley
lunedì, novembre 30, 2009
CHi parla
Phastidio sintetizza in maniera interssante quanto sta avvenendo fra Dubai e la Grecia, oltre a dare un esempio di qualcosa che qui si sostiene da anni: per uscire dalla crisi è indispensabile apprendere di nuovo che il rischio esiste sempre, dove c'è rendimento - ed il rischio di fallimento e ristrutturazione c'è sempre. Cercare di azzerare il rischio tramite il binomio regolamentazione + bailout è una illusione statalista, destinata al fallimento; l'unico modo per disciplinare i banchieri è ripristinare la paura delle conseguenze di una decisione sbagliata.
Ogni alternativa è illusoria, vista la presenza di una fiorente industria specializzata nell'aggirare ogni regolamentazione, per quanto draconiana o bizantina, lasciando alle banche i soli vantaggi dei salvataggi. Per banchieri e speculatori, sarebbe invece impossibile evitare l'ira dei propri investitori, se le perdite derivanti dai propri errori venissero pagate in prima persona.
Non sarei così certo che Dopo Dubai i mercati parlano a Dublino affinché Roma intenda. O meglio, non credo che Roma sia la nazione più a rischio. L'Italia è in una sgradevole situazione debitoria, ma relativamente stabile. Al contrario di nazioni come Grecia e Spagna, il cui squilibri sono potenzialmente devastanti, oppure dei giganti anglosassoni, che stanno per scoprire i dolori dell'assenza di equilibrio fiscale.
lunedì, settembre 28, 2009
Siamo davvero usciti dalla depressione bancaria?
 Come si può notare, una sola regione ha raccolto più capitale di quanto ne servisse per pareggiare le perdite del 2008-2009: l'Asia. Praticamente ovunque, invece, i governi e le imprese stanno ancora cercando di recuperare le perdite annunciate. Tutto ciò che non possono essere finanziate attraverso i mercati obbligazionari o tramite finanziamento pubblico già scricchiolante dovrà venire da aumenti di capitale, creando pressioni sui mercati azionari.
Come si può notare, una sola regione ha raccolto più capitale di quanto ne servisse per pareggiare le perdite del 2008-2009: l'Asia. Praticamente ovunque, invece, i governi e le imprese stanno ancora cercando di recuperare le perdite annunciate. Tutto ciò che non possono essere finanziate attraverso i mercati obbligazionari o tramite finanziamento pubblico già scricchiolante dovrà venire da aumenti di capitale, creando pressioni sui mercati azionari.Una lettura ottimistica della tabella di cui sopra presuppone inoltre che le svalutaizoni sui crediti siano finite e che non vi saranno ulteriori perdite di venire da, diciamo, mutui residenziali, prestiti agli studenti, prestiti auto, prestiti sulle carte di credito. Si presume anche che le banche banche non stiano diciamo così stiracchiando la realtà sul reale stato dle proprio bilancio, come è invece avvenuto negli ultimi anni. Per quanto riguarda l'economia mondiale, gli investitori in tutto il mondo vedono il rally dei mercati azionari , se misurato dai minimi di Marzo - e deducono che la battaglia è finita. In un certo senso, la battaglia è finita: Lehman è stata sacrificata, ma sotto tutti gli altri aspetti, le banche hanno vinto, e tutti gli altri hanno perso.
Hat tip:The Price of Everything.
domenica, settembre 27, 2009
Banche centrali, inciuci nazionali, perdite universali
In Italia, le banche hanno ridotto drasticamente i prestiti a piccole e medie imprese, mentre hanno ampliato marginalmente quelli alle grandi imprese e, soprattutto, gli acquisti di titoli di Stato, usando i fondi generosamente prestati dalle Banche Centrali. Una strategia controversa e contraria agli scopi dei governi, ma derivante proprio dalle politiche governative che avevano come scopo la tutela dei risparmiatori e l’espansione, anche drogata del credito. Le politiche di tassi a zero hanno, soprattutto, gettato benzina sul fuoco dei mercati finanziari, generando quella che somiglia all’ennesima bolla. Non parliamo soltanto di speculazioni di Borsa, ma anche e soprattutto del cosiddetto carry trade di tasso: le banche prendono a prestito a brevissimo e a tassi quasi nulli dalla Banca Centrale Europea ed investono in titoli di Stato a lungo termine, lucrando la differenza. La sola Banca Intesa, ad esempio, ha incrementato di 18 miliardi di euro il proprio portafoglio titoli, mentre riduceva di circa 8 miliardi i prestiti alla clientela. Il trucco è conosciuto, ma poco citato da governi e banche centrali. I governi devono collocare quantità sempre maggiori di debito e quindi accettano volentieri qualsiasi aiuto, anche quello di banche che prendono a prestito da un ente statale (la BCE) per prestare ad altri (i governi). Le banche centrali desiderano un aumento delle riserve di capitale delle banche; il carry trade fornisce notevoli utili che possono essere messi a riserva. Il rischio è che, quando ariverà l’inevitabile rialzo dei tassi, le banche non siano in grado di scaricare le proprie posizioni e quindi comincino ad accumulare perdite rovinose. Sino ad allora, siamo di fronte all’ennesimo sussidio, pagato dal contribuente, che aiuta a nascondere il nocciolo del problema bancario: il vero padrone, in un istituto di credito regolamentato,non è soltanto l’azionista, che conta poco rispetto ad una dirigenza teoricamente vigilata e perennemente sostenuta da coloro che la dovrebbero controllare. La stessa autorità di vigilanza si arroga parzialmente il ruolo degli azionisti; gode di poteri d’intervento inauditi in ogni altro segmento di un’economia di mercato, ma preferisce dimenticarsene quando la stampa ed i politici aggrediscono un “capitalismo selvaggio” che nel settore bancario non è mai arrivato.
PRESTITI E DOLORI- Per quanto riguarda i prestiti alle grandi imprese, gettiamo uno sguardo negli USA, dove per almeno alcune categorie di prestiti le banche sono ancora obbligate e riportare il reale valore dei prestiti e non il valore “storico”. Ebbene, secondo uno studio annuale ufficiale, le perdite sono triplicate nel corso del 2009 , arrivando ai 53 miliardi di dollari. Le illusioni riguardo il basso rischio dei prestiti alle blue chip ed alle mega-operazioni societarie si è rapidamente rivelata fallace, come invano avevano ripetuto per anni gli stessi analisti che adesso vengono accusati, paradossalmente, di “liberismo selvaggio”. I dirigenti delle banche commerciali faranno probabilmente spallucce: si tratta di ulteriori munizioni nella battaglia per ottenere ancora più aiuti di stato, espliciti o impliciti. Le banche nostrane dovrebbero prestare attenzione: le grandi aziende possono essere tranquillamente accompagnate al mercato obbligazionario, invece d’impiegare capitale bancario prezioso prestando loro a tassi poco redditizi: le nostre banche prestano normalmente a tassi tropo ridotti ai grandi gruppi, rifacendosi poi su tutti gli altri clienti. L’unica eccezione sono le operazioni rischiose, i prestiti forniti a società grandi, ma fragili, il cui maggior pregio è la capacità relazionale del proprietario. I nomi di Zunino e di altri “capitani coraggiosi”, del presente e del recente passato, tornano alla mente. Se il nostro premier smettesse di parlare di ciò che non conosce e rivolgesse gli occhi verso casa, troverebbe “speculatori” ben più meritevoli di sanzione. Purtroppo, sia l’attuale governo, come il precedente e l’opposizione, sembrano soddisfatti con posizioni demagogiche ed autolesionistiche. Le normative seguite al caso Parmalat hanno chiuso il mercato del credito per quasi tutte le aziende italiane, bloccandone lo sviluppo; nel frattempo, invece, il mercato obbligazionario aziendale cresceva d’importanza in tutta Europa. Tale chiusura non ha portato alcun vantaggio alla tutela dei risparmiatori, lasciati in balia di strumenti ancora meno trasparenti ed ha lasciato le banche come uniche interlocutrici delle grandi aziende, regalando loro un business molto politico, ma non molto redditizio, che sottrae capitale e talenti che potrebbero essere impiegati per sostenere la vera spina dorsale dell’economia: le piccole e medie imprese. La soluzione non è una ulteriore camicia di forza, ma la rimozione dei vincoli che garantiscono alle banche la propria rendita di posizione.
Crosspost su Giornalettismo
Posted by J.C. Falkenberg at 9:41 PM |
Labels: Banca d'Italia , Banche , Bankitalia , cartelli , Economia , grandi aziende , prestiti , Regolamentazione , vigilanza
giovedì, settembre 24, 2009
Banche, prove tecniche di sganciamento
Il 29 Settembre si svolgeranno i CdA di Unicredit ed IntesaSanpaolo. In quella sede, la dirigenza di entrambe le banche avrebbe intenzione di presentare misure straordinarie per raccogliere capitale, evitando il ricorso ai Tremonti bond. Come avevamo già riportato, Intesa punterebbe ad emettere uno strumento ibrido, una sorta di Tremonti Bond collocato presso investitori istituzionali. Unicredit starebbe pianificando un aumento di capitale vero e proprio, ma sinora il principale scoglio era la resistenza delle fondazioni bancarie che, congiuntamente, controllano la banca. Queste, per legge, dovrebbero ridurre gradualmente la propria quota, in modo da potersi concentrare sulla propria missione di supporto del territorio e delle opere a valenza sociale. In pratica, il processo è sempre stato molto lento e le partecipazioni bancarie sono state un utile fonte di cassa e di potere politico. Durante la crisi, Profumo ha però azzerato i dividendi pagati da Unicredit, esacerbando i malumori fra i propri azionisti-rentiers ed un aumento di capitale, privo del supporto degli azionisti più rilevanti, verrebbe accolto con notevole scetticismo. Uno spiraglio si sarebbe aperto ieri: alcune fondazioni sarebbero disposte a partecipare, se il dividendo venisse ristabilito. Adesso che la liquidità regalata dalle banche centrali permette profitti facili, almeno sulla carta, la proposta potrebbe essere accettata senza creare preoccupazioni sul mercato riguardo alla stabilità finanziaria della banca.
Mentre le sconquassate Banca Popolare di Milano e Banco Popolare, con l’aggiunta quasi certa di Monte dei Paschi e credito Valtelllinese, non hanno avuto altra scelta che piegare il capo ed accettare l’aiuto di Tremonti, le due banche maggiori potrebbero evitarlo. L’antistatalismo c’entra poco: il settore bancario ha sempre goduto e tuttora gode di ampi privilegi, in cambio della sottomissione ai voleri della banca centrale e di alcuni segmenti della classe politica, ma non ha mai dovuto rinunciare ad ogni margine di manovra e sottomettersi ad impegni espliciti, quali quelli richiesti dal ministro valtellinese; la distanza ideologica fra questo governo e la dirigenza di Intesa e Unicredit, inoltre, non aiuta di certo.
Se Tremonti volesse davvero riformare il settore o rompere le reni alla casta bancaria, abbonderebbero strumenti meno rozzi e per una volta estranei all’arsenale socialista . Per un governo sedicente liberale, esistono rimedi molto migliori di una battaglia dirigista per imporre dall’alto diktat politici e populisti, addolciti dalla carota avvelenata del denaro pubblico. Meglio, molto meglio indagare le cause dell’elevato costo dei servizi bancari in Italia e proporre semplici cure liberali. Invece di lamentarsi per le dimensioni delel banche in Italia, meglio sarebbe rimuovere gli ostacoli all’aumento della competizione bancaria, unico modo per ridurre i prezzi praticati alla clientela; aiuterebbe molto eliminare i sussidi e le garanzie che ancora fanno pretendere che nessuna banca, soprattutto le grandi, fallirà mai. E’ ora di rinunciare al patto scellerato per cui un cartello bancario è autorizzato a rapinare una clientela che, dal canto suo, non si prende neppure la briga di confrontare prezzi e condizioni, perché , tanto , “le banche non saltano”. Se questo governo si ricordasse di essere di centrodestra e non una riedizione del peggior socialcomunismo all’amatriciana o una replica economica del corporativismo da Ventennio, potrebbe farci un pensierino.
Crosspost con Giornalettismo e Macromonitor
Posted by J.C. Falkenberg at 3:57 PM |
Labels: Banche , Intesa Sanpaolo , Regolamentazione , Unicredito
lunedì, settembre 14, 2009
Lehman, un anno vissuto pericolosamente
Banche centrali e governi hanno dato la risposta sbagliata al problema giusto. FALLIMENTO A SORPRESA -Il 15 Settembre del 2008 il management di Lehman Brothers gettava la spugna ed annunciava che avrebbe portato i libri in Tribunale. Per la prima volta nella storia recente, il governo americano accettava di lasciar dichiarare bancarotta ad una primaria istituzione finanziaria, dopo che le trattative con l’inglese Barclays non erano andate a buon fine. Si verificava quello che i trader di tutto il mondo avevano considerato un puro caso di BANCHE O NON-BANCHE? Il problema maggiore è stato che le cosiddette “investment banks” non erano, in teoria, banche nel senso comune del termine. Non avevano la possibilità di aprire conti correnti e di raccogliere depositi presso il pubblico, né di offrire direttamente prestiti o mutui agli individui. In cambio, erano soggette a norme di vigilanza meno stringenti rispetto alle banche commerciali propriamente dette. Le uniche, parziali, eccezioni erano le due banche universali J.P.Morgan e Citigroup, che si A partire dal 2004-2005, la manipolazione dei tassi d’interesse da parte delle banche centrali e la manipolazione del mercato dei cambi da parte della Cina e di altre nazioni asiatiche aveva creato una condizione di eccessiva liquidità: tassi troppo bassi avevano incentivato l’assunzione di debito, mentre la domanda di titoli in dollari aveva distorto la percezione del rischio. La bolla che ne seguì fu particolarmente severa nel campo delle cartolarizzazioni garantite da mutui; Il fatto che i prezzi nominali delle case non fossero mai calati, a livello nazionale, dai tempi della Grande Depressione fece nascere la percezione che i mutui sottostanti alle cartolarizzazioni fossero molto più sicuri di quanto fosse ragionevole prevedere; i bassi tassi ebbero un doppio effetto: incentivarono chi voleva indebitarsi per comprar casa, aumentando l’offerta; stimolarono gli investitori a caccia di rendimento ad abbandonare i titoli di Stato e ad acquistare le cartolarizzazioni, che portavano rating molto elevati. Ad un certo punto, l’euforia contagiò le banche d’affari; iniziarono a credere alla propria stessa propaganda. Una ad una, affiancarono al ruolo di intermediari quello di investitori; prive di depositi e di raccolta a lungo termine, s’indebitarono massicciamente a brevissimo termine sul mercato monetario e trattennero nei portafogli d’investimento grandi quantità di titoli illiquidi, in particolare mutui residenziali e commerciali. Il rischio, invece di essere distribuito fra investitori professionisti, rimaneva immagazzinato nei veicoli fuori bilancio di proprietà di banche commerciali e broker. Gli azionisti vedevano, anche se solo parzialmente, ma soltanto una minoranza si preoccupava: la strategia fruttava denaro, il rischio sembrava ridotto e tutti si aspettavano che, in caso di problemi, il Governo sarebbe intervenuto. I creditori vedevano, ma anni di mercato toro e di supporto automatico da parte delle banche centrali li avevano resi compiacenti: pur di guadagnare interessi, si accettavano tassi ridotti e, soprattutto, poche garanzie sui prestiti a breve. BOLLA E CROLLO - Fra il 2007 e l’inizio del 2008, lo scoppio della bolla immobiliare americana mise in crisi il mercato: l’assunto centrale che i prezzi degli immobili negli USA non potevano scendere era stato smentito, alterando drasticamente il profilo di rischio percepito, con un quasi immediato crollo dei prezzi. A questo punto, i giganteschi magazzini si trasformarono rapidamente in una formidabile pietra al collo: gli aumenti di valore negli anni erano stati distribuiti agli azionisti sotto forma di dividendi, tramite denaro presto a prestito impiegando quegli stessi titoli come garanzia. Adesso, le svalutazioni facevano scattare richieste di integrazioni di tali garanzie, aumentando la necessità di liquidità da parte del debitore. Fu la scintilla che innescò la grande crisi di liquidità: il credito a breve e brevissimo termine si prosciugò quasi immediatamente, portando al dissesto i “giocatori” più deboli e meno liquidi. Ogni intermediario cominciò PROTEGGERE LE TUBATURE - L’unico obbiettivo di una banca centrale, di fronte ad una crisi finanziaria, dovrebbe essere quello di proteggere il funzionamento del sistema, laddove gli accordi privati non garantiscano tale sicurezza; proteggere una singola banca, i suoi azionisti o i suoi obbligazionisti non è necessario e neppure desiderabile, perché significherebbe premiare imprese inefficienti ed investitori miopi, impedendo invece a d investitori banche più abili o prudenti di aumentare la propria  studio sino a pochi mesi prima: una delle “Bulge Bracket“, le grandi banche d’affari di Wall Street, si avviava alla liquidazione. Si apriva così uno dei più grandi collaudi della solidità dell’infrastruttura che sostiene il sistema finanziario moderno. Il risultato è incoraggiante: il mondo non è crollato e il sistema ha imparato a correggere i propri errori; il risultato opposto a quelli ottenuti dai salvataggi governativi, che hanno incoraggiato un aumento di rischi e dimensioni, nell’attesa che chi è “troppo grande per fallire” verrà sempre salvato, soprattutto se politicamente fedele. La caduta di Lehman Brothers avvenne dopo alcune settimane di attività febbrile intorno al settore delle banche d’affari americane, particolarmente vulnerabili alla crisi finanziaria in atto già da quasi un anno. La dichiarazione di fallimento fu totalmente inaspettata, per motivi politici più che finanziari. Il CDS e le obbligazioni Lehman scambiavano già a livelli che suggerivano un’imminente chiusura, ma molti operatori davano per scontato che il governo e la Federal Reserve sarebbero intervenuti, come accaduto con Bear Stearns. La più piccola delle bulge bracket firms aveva subito una crisi di liquidità sei mesi prima ed era stata acquistata dalla concorrente J.P. Morgan, dopo che la Federal Reserve aveva acconsentito a farsi carico di decine di miliardi delle eventuali perdite sui titoli in portafoglio alla banca d’affari. Quasi contemporaneamente a Lehman, Goldman Sachs e Morgan Stalney furono costrette a cercare iniezioni di capitale da nuovi azionisti, per tamponare le falle in bilancio, Merrill Lynch fu costretta a vendersi al colosso bancario Bank of America (BoA); il Ministero del Tesoro e il governatore della Fed Bernanke sono stati accusati di avere esercitato indebite pressioni sulla dirigenza della banca acquirente, minacciando ritorsioni nel caso la banca non avesse chiuso l’operazione . L’acquisto di Merrill Lynch è costato miliardi di dollari in svalutazioni a BoA ed ai suoi azionisti, mentre la Federal Reserve è in rosso per circa 8 miliardi di dollari sui portafogli incamerati per facilitare l’acquisizione di Bear Stearns. Per contrasto, la liquidazione di Lehman sta procedendo in maniera relativamente ordinata. Da cosa nasce la disparità di trattamento fra Bear Stearns, Merrill Lynch e Lehman? Perché non si è scelta la strada della liquidazione anche per Bear Stearns, o per Merrill Lynch?
studio sino a pochi mesi prima: una delle “Bulge Bracket“, le grandi banche d’affari di Wall Street, si avviava alla liquidazione. Si apriva così uno dei più grandi collaudi della solidità dell’infrastruttura che sostiene il sistema finanziario moderno. Il risultato è incoraggiante: il mondo non è crollato e il sistema ha imparato a correggere i propri errori; il risultato opposto a quelli ottenuti dai salvataggi governativi, che hanno incoraggiato un aumento di rischi e dimensioni, nell’attesa che chi è “troppo grande per fallire” verrà sempre salvato, soprattutto se politicamente fedele. La caduta di Lehman Brothers avvenne dopo alcune settimane di attività febbrile intorno al settore delle banche d’affari americane, particolarmente vulnerabili alla crisi finanziaria in atto già da quasi un anno. La dichiarazione di fallimento fu totalmente inaspettata, per motivi politici più che finanziari. Il CDS e le obbligazioni Lehman scambiavano già a livelli che suggerivano un’imminente chiusura, ma molti operatori davano per scontato che il governo e la Federal Reserve sarebbero intervenuti, come accaduto con Bear Stearns. La più piccola delle bulge bracket firms aveva subito una crisi di liquidità sei mesi prima ed era stata acquistata dalla concorrente J.P. Morgan, dopo che la Federal Reserve aveva acconsentito a farsi carico di decine di miliardi delle eventuali perdite sui titoli in portafoglio alla banca d’affari. Quasi contemporaneamente a Lehman, Goldman Sachs e Morgan Stalney furono costrette a cercare iniezioni di capitale da nuovi azionisti, per tamponare le falle in bilancio, Merrill Lynch fu costretta a vendersi al colosso bancario Bank of America (BoA); il Ministero del Tesoro e il governatore della Fed Bernanke sono stati accusati di avere esercitato indebite pressioni sulla dirigenza della banca acquirente, minacciando ritorsioni nel caso la banca non avesse chiuso l’operazione . L’acquisto di Merrill Lynch è costato miliardi di dollari in svalutazioni a BoA ed ai suoi azionisti, mentre la Federal Reserve è in rosso per circa 8 miliardi di dollari sui portafogli incamerati per facilitare l’acquisizione di Bear Stearns. Per contrasto, la liquidazione di Lehman sta procedendo in maniera relativamente ordinata. Da cosa nasce la disparità di trattamento fra Bear Stearns, Merrill Lynch e Lehman? Perché non si è scelta la strada della liquidazione anche per Bear Stearns, o per Merrill Lynch? configuravano come gruppi diversificati, comprendenti sia una società che esercitava attività d’intermediazione e consulenza ad aziende e investitori, sia una serie di banche commerciali. Le altre banche d’affari erano quasi soltanto dedite alla compravendita di titoli e di portafogli di prestiti originati da altre banche; sino al 2005, soltanto le “anomale” Citigroup e J.P.Morgan mantenevano grandi portafogli titoli per investimento, anche se tutte detenevano ”magazzini” impiegati per fornire prezzi in maniera continuativa (il cosiddetto market-making) oppure per fungere da materia prima per costruire titoli strutturati. Non a caso, il termine gergale per definirle negli ambienti finanziari è “broker”, ossia intermediari puri.
configuravano come gruppi diversificati, comprendenti sia una società che esercitava attività d’intermediazione e consulenza ad aziende e investitori, sia una serie di banche commerciali. Le altre banche d’affari erano quasi soltanto dedite alla compravendita di titoli e di portafogli di prestiti originati da altre banche; sino al 2005, soltanto le “anomale” Citigroup e J.P.Morgan mantenevano grandi portafogli titoli per investimento, anche se tutte detenevano ”magazzini” impiegati per fornire prezzi in maniera continuativa (il cosiddetto market-making) oppure per fungere da materia prima per costruire titoli strutturati. Non a caso, il termine gergale per definirle negli ambienti finanziari è “broker”, ossia intermediari puri. ad insistere nel rispetto dei termini delle garanzie sui prestiti a clienti e controparti, esacerbando il problema. Banche ed investitori ricordarono improvvisamente quanto dipendenti dai finanziamenti a breve fossero alcune istituzioni e smisero di far loro credito, oppure pretesero ampie garanzie, non soltanto sulle cartolarizzazioni, ma per qualunque linea di credito ed operazione finanziaria da rinnovare. I più forti e prudenti non ebbero particolari problemi. Per i più aggressivi ed indebitati, le cose divennero rapidamente drammatiche. Era l’inizio di uno dei cicli di crisi e “pulizia” del mercato finanziario, comuni sino agli anni ‘90, ma sconosciuti da quasi 15 anni. Bear Stearns era uno dei broker più aggressivi: storicamente la più piccola e spericolata fra le “bulge brackets”, non era soltanto molto esposta alla crisi immobiliare. Era anche attivissima nelle operazioni con gli hedge fund , fornendo loro non soltanto servizi di intermediazione, ma anche credito a breve termine. Lehman Brothers era storicamente forte nei settori delle commodities e del reddito fisso, settori dove i clienti richiedevano credito, ma si era sempre comportata in maniera decisamente prudente. Sino al 2006, almeno, quando il suo management decise di buttarsi anch’esso nella speculazione in conto proprio, esattamente quando cominciavano i primi dubbi sulla bolla. Bear Stearns ebbe fortuna: fu la prima a vedersi rifiutare credito dal mercato e la Fed, pur non essendo tecnicamente obbligata a farlo, fece pressioni per un salvataggio. Lehman non fu così fortunata: la banca inglese Barclays si era inizialmente offerta per acquisire Lehman in cambio di un aiuto di Stato simile a quello offerto a J.P.Morgan per Bear Stearns. L’incapacità di raggiungere un accordo portò alla chiusura dei colloqui ed al fallimento. Sui motivi del mancato accordo, le interpretazioni abbondano e, sicuramente, le maggiori dimensioni di Lehman e la nazionalità non americana di Barclays furono grossi ostacoli, anche se un’interpretazione maggiormente politica non può essere esclusa. Merrill Lynch venne “salvata” perché si ritene che un secondo fallimento, una settimana dopo quello di Lehman, avrebbe destabilizzato eccessivamente il sistema; la Fed ed il Tesoro, d’altronde, stavano già sussidiando per decine di miliardi di dollari le banche commerciali, implicate nello stesso genere di speculazioni. E’ quello che sarebbe davvero successo? Non esistevano davvero salvaguardie alla stabilità del sistema, al di fuori di un intervento della Fed? La legislazione sul fallimento e sul commissariamento bancario sarebbero davvero state inutili? Il fato, così differente, di Lehman rispetto alle altre banche ci permette di rispondere ad alcuni interrogativi, comparando i costi ed i risultati dell’intervento governativo, con i costi ed il risultato di una ristrutturazione tramite il Tribunale. Le risposte sono meno ovvie di quanto ci si potrebbe aspettare, anche senza considerareil maggior difetto dei salvataggi statali: la conferma che per i grandi, alla fine, paga sempre Pantalone.
ad insistere nel rispetto dei termini delle garanzie sui prestiti a clienti e controparti, esacerbando il problema. Banche ed investitori ricordarono improvvisamente quanto dipendenti dai finanziamenti a breve fossero alcune istituzioni e smisero di far loro credito, oppure pretesero ampie garanzie, non soltanto sulle cartolarizzazioni, ma per qualunque linea di credito ed operazione finanziaria da rinnovare. I più forti e prudenti non ebbero particolari problemi. Per i più aggressivi ed indebitati, le cose divennero rapidamente drammatiche. Era l’inizio di uno dei cicli di crisi e “pulizia” del mercato finanziario, comuni sino agli anni ‘90, ma sconosciuti da quasi 15 anni. Bear Stearns era uno dei broker più aggressivi: storicamente la più piccola e spericolata fra le “bulge brackets”, non era soltanto molto esposta alla crisi immobiliare. Era anche attivissima nelle operazioni con gli hedge fund , fornendo loro non soltanto servizi di intermediazione, ma anche credito a breve termine. Lehman Brothers era storicamente forte nei settori delle commodities e del reddito fisso, settori dove i clienti richiedevano credito, ma si era sempre comportata in maniera decisamente prudente. Sino al 2006, almeno, quando il suo management decise di buttarsi anch’esso nella speculazione in conto proprio, esattamente quando cominciavano i primi dubbi sulla bolla. Bear Stearns ebbe fortuna: fu la prima a vedersi rifiutare credito dal mercato e la Fed, pur non essendo tecnicamente obbligata a farlo, fece pressioni per un salvataggio. Lehman non fu così fortunata: la banca inglese Barclays si era inizialmente offerta per acquisire Lehman in cambio di un aiuto di Stato simile a quello offerto a J.P.Morgan per Bear Stearns. L’incapacità di raggiungere un accordo portò alla chiusura dei colloqui ed al fallimento. Sui motivi del mancato accordo, le interpretazioni abbondano e, sicuramente, le maggiori dimensioni di Lehman e la nazionalità non americana di Barclays furono grossi ostacoli, anche se un’interpretazione maggiormente politica non può essere esclusa. Merrill Lynch venne “salvata” perché si ritene che un secondo fallimento, una settimana dopo quello di Lehman, avrebbe destabilizzato eccessivamente il sistema; la Fed ed il Tesoro, d’altronde, stavano già sussidiando per decine di miliardi di dollari le banche commerciali, implicate nello stesso genere di speculazioni. E’ quello che sarebbe davvero successo? Non esistevano davvero salvaguardie alla stabilità del sistema, al di fuori di un intervento della Fed? La legislazione sul fallimento e sul commissariamento bancario sarebbero davvero state inutili? Il fato, così differente, di Lehman rispetto alle altre banche ci permette di rispondere ad alcuni interrogativi, comparando i costi ed i risultati dell’intervento governativo, con i costi ed il risultato di una ristrutturazione tramite il Tribunale. Le risposte sono meno ovvie di quanto ci si potrebbe aspettare, anche senza considerareil maggior difetto dei salvataggi statali: la conferma che per i grandi, alla fine, paga sempre Pantalone.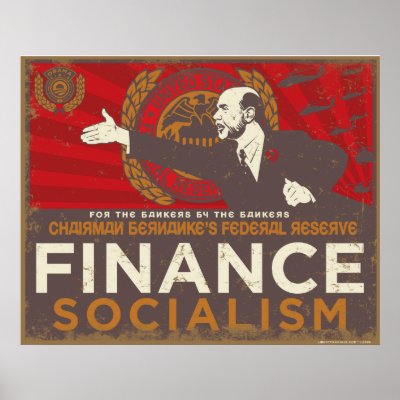 quota di mercato, aumentando l’efficienza e l’innovazione nel settore. L’intervento governativo straordinario effettuato dalla Fed nel caso di Bear e di Merrill non ha danneggiato il sistema dei pagamenti, ma non è chiaro se fosse necessario; l’nfrsatruttura di mercato sembra avere infatti retto il colpo del fallimento di Lehman in maniera dolorosa ma istruttiva . Esiste già, infatti, un sistema di convenzioni, un intreccio di contratti standard,codificato dalle associazioni che fungono da forum di consultazione fra le banche attive su derivati e sistemi di pagamenti. Tali convenzioni dovrebbero minimizzare i rischi che il fallimento di una controparte metta a rischio la validità delle operazioni in derivati con i propri clienti e con le altre banche. Una parte fondamentale di questo intreccio è costituito da una sorta di “rete di salvataggio”, un insieme di clausole e di pratiche che dovrebbe assicurare una ordinata conclusione dell’operazione anche in caso di insolvenza di una delle controparti; ogni operazione viene svolta seguendo queste pratiche convenzionali. Questo sistema ha funzionato sorprendentemente bene, considerati i timori derivanti dalla crisi e dal fallimento di Lehman. Le controparti finanziarie della banca fallita sono riuscite ad ottenere quanto loro dovuto ed a riaprire nuovi contratti con altre banche, senza eccessivi costi; le corti fallimentari implicate non hanno frapposto ostacoli, permettendo una rapida risoluzione dei contratti di mercato, anche quando non si trattava di operazioni concluse su mercati regolamentati. Il funzionamento dei mercati dei derivati e dei pagamenti ha retto al colpo, quindi, anche se è risultata evidente la necessità di una serie di profonde riforme, alle quali stanno lavorando sia le autorità di vigilanza che, soprattutto, banche ed altri operatori. Le attività caratteristiche di Lehman sono state acquisite da Barclays e dalla giapponese Nomura, che hanno riassunto la maggior parte dei dipendenti. Invece di una serie di interventi ad hoc, ottimi dal punto di vista della pubblicità, del marketing politico e della propaganda statalista, ci dovremmo chiedere se non sarebbe stata sufficiente una interpretazione flessibile delle leggi sul commissariamento bancario ed, al limite, una riforma della nomativa. Persino la compassata BIS, la Banca dei regolamenti Internazionali si è espressa in tal senso, criticando l’ipotesi che esistano banche “troppo grandi per fallire”. Non è un caso che le grandi banche sono di nuovo impegnate nello stesso comportamento “speculativo” di un anno fa: la lezione tratta dal 2008 è che basta essere abbastanza grandi e abbastanza obbedienti e si verrà salvati. Qualche Lehman in più, fra le grandi banche, ci avrebbe evitato l’interferenza politica nei processi di allocazione di capitale e credito. Soprattutto, senza l’iperattivismo di banche centrali e governi, , ci saremmo evitati altre bolle speculative, che iniziano sempre con la manipolazione dei mercati da parte di coloro i quali ne dovrebbero essere i custodi e continuano, anche oggi, grazie alla convinzione che alla fine la politica permetterà a tutti di non pagare il conto. Quello lo pagano i cittadini, con calma.
quota di mercato, aumentando l’efficienza e l’innovazione nel settore. L’intervento governativo straordinario effettuato dalla Fed nel caso di Bear e di Merrill non ha danneggiato il sistema dei pagamenti, ma non è chiaro se fosse necessario; l’nfrsatruttura di mercato sembra avere infatti retto il colpo del fallimento di Lehman in maniera dolorosa ma istruttiva . Esiste già, infatti, un sistema di convenzioni, un intreccio di contratti standard,codificato dalle associazioni che fungono da forum di consultazione fra le banche attive su derivati e sistemi di pagamenti. Tali convenzioni dovrebbero minimizzare i rischi che il fallimento di una controparte metta a rischio la validità delle operazioni in derivati con i propri clienti e con le altre banche. Una parte fondamentale di questo intreccio è costituito da una sorta di “rete di salvataggio”, un insieme di clausole e di pratiche che dovrebbe assicurare una ordinata conclusione dell’operazione anche in caso di insolvenza di una delle controparti; ogni operazione viene svolta seguendo queste pratiche convenzionali. Questo sistema ha funzionato sorprendentemente bene, considerati i timori derivanti dalla crisi e dal fallimento di Lehman. Le controparti finanziarie della banca fallita sono riuscite ad ottenere quanto loro dovuto ed a riaprire nuovi contratti con altre banche, senza eccessivi costi; le corti fallimentari implicate non hanno frapposto ostacoli, permettendo una rapida risoluzione dei contratti di mercato, anche quando non si trattava di operazioni concluse su mercati regolamentati. Il funzionamento dei mercati dei derivati e dei pagamenti ha retto al colpo, quindi, anche se è risultata evidente la necessità di una serie di profonde riforme, alle quali stanno lavorando sia le autorità di vigilanza che, soprattutto, banche ed altri operatori. Le attività caratteristiche di Lehman sono state acquisite da Barclays e dalla giapponese Nomura, che hanno riassunto la maggior parte dei dipendenti. Invece di una serie di interventi ad hoc, ottimi dal punto di vista della pubblicità, del marketing politico e della propaganda statalista, ci dovremmo chiedere se non sarebbe stata sufficiente una interpretazione flessibile delle leggi sul commissariamento bancario ed, al limite, una riforma della nomativa. Persino la compassata BIS, la Banca dei regolamenti Internazionali si è espressa in tal senso, criticando l’ipotesi che esistano banche “troppo grandi per fallire”. Non è un caso che le grandi banche sono di nuovo impegnate nello stesso comportamento “speculativo” di un anno fa: la lezione tratta dal 2008 è che basta essere abbastanza grandi e abbastanza obbedienti e si verrà salvati. Qualche Lehman in più, fra le grandi banche, ci avrebbe evitato l’interferenza politica nei processi di allocazione di capitale e credito. Soprattutto, senza l’iperattivismo di banche centrali e governi, , ci saremmo evitati altre bolle speculative, che iniziano sempre con la manipolazione dei mercati da parte di coloro i quali ne dovrebbero essere i custodi e continuano, anche oggi, grazie alla convinzione che alla fine la politica permetterà a tutti di non pagare il conto. Quello lo pagano i cittadini, con calma.
Crosspost from Giornalettismo
Posted by J.C. Falkenberg at 6:07 PM |
Labels: Banche , Bear Stearns , Lehman
lunedì, settembre 07, 2009
Tremonti, smemorato perché politico
Il ministro dell’Economia si scaglia contro le banche ed è in ottima compagnia: al G-20 tutti hanno capito che la caccia al banchiere paga. Purtroppo, la demagogia porta a soluzioni inutili nel migliore dei casi, dannose nel peggiore. E nasconde agli elettori le responsabilità dei politici. L’accordo di massima uscito dal G-20 è un miscuglio di palliativi, buone intenzioni e caccia alle streghe. Le proposte sultetto ai salari, ad esempio, sono di natura prettamente demagogica, ma l’elettore che vede il proprio governo gettare miliardi di euro per evitare ilcommissariamento di una banca non vuole riforme; istintivamente, vuole vendetta. Tagliare i salari dei manager bancari soddisfa tale sete di vendetta, ponendo nel frattempo la classe politica in una luce positiva, quali i salvatori del sistema. Poco importa che la crisi sia nata proprio dove l’intervento e la sorveglianza delle autorità statali era più ampia, non dove erano meno coinvolte. Poco importa che le crisi bancarie peggiori degli ultimi anni sono avvenute senza alcun bisogno di innovazione finanziaria ed in contesti dove i compensi erano modesti: i bancari svedesi che portarono il proprio sistema finanziario al collasso negli anni’90 non guadagnavano certo bonus principeschi; negli stessi anni, Ventriglia e soci riuscirono ad affondare il Banco di Napoli senza stipendi d’oro, ma con una grossa mano da parte della politica. L‘atteggiamento apocalittico a cui ministro Giulio Tremonti si è lasciato andare è soltanto l’espressione più teatrale di questa strategia: noi italiani, si sa, adoriamo il melodramma e le scenate e Tremonti, ormai vero politico, rinuncia alla tecnica ed abbraccia la propaganda pauperistica per amor di palcoscenico. In realtà, il ministro sta abbaiando sotto l’albero sbagliato, seppure, almeno in parte, per i motivi giusti. AIUTI SI’, AIUTI NO - Se Tremonti ragionasse ancora da tecnico, saprebbe che gli istituti che non accettano il Tremonti-Bond non sono traditori della patria, come li ha praticamente definiti. Nell’ipotesi più caritatevole, sono istituti virtuosi, che non hanno bisogno degli aiuti e Tremonti dovrebbe rallegrarsi di non dover metter mano al portafogli degli italiani. In un’interpretazione più maliziosa, sono miracolati dell’intervento politico, che ha alterato le regole del gioco rendendo meno pressante la necessità di raccogliere capitali. Ricordiamo, infatti, che anche il ministro Tremonti ha plaudito all’alterazione delle norme contabili che esentavano le banche dal riconoscere le perdite sui titoli tossici in portafoglio. Il Ministro si è anche in passato scagliato contro Basilea-2 , mai davvero entrata in vigore, perché avrebbe richiesto che anche i prestiti alle aziende venissero valutati in base alla solidità dei debitori. Se il Ministro avesse voluto che le banche ricapitalizzassero, avrebbe dovuto astenersi dall’interferire ( e con lui i suoi pari del G30): la ricapitalizzazione sarebbe divenuta ineludibile, per l’intero settore e si sarebbe potuti ripartire con una trasparente visione della gravità del problema. ALLA RADICE DEI PROBLEMI - Il ministro si sta insomma lamentando delle conseguenze di interventi che aveva rumorosamente appoggiato. Allo stesso modo, sorprende l’altro punto dell’intervento tremontiano, ossia la lamentela che le banche sarebbero troppo preoccupate della salute dei propri bilanci e della tutela dei propri azionisti, rispetto al “bene comune”. Se i manager della banche si fossero preoccupati davvero dei propri azionistie dei propri bilanci, non avrebbero preso rischi eccessivi, ben consci che gli utili elevati spesso comportano rischi elevati. Quello che ha favorito la cultura del rischio ad ogni costo non è l’eccessivo potere degli azionisti. E’ stata l’autoreferenzialità dei dirigenti bancari, protetti dalla legislazione speciale che governa il mondo della finanza: in un mondo dove l’ultima parola spetta per definizione alle autorità di vigilanza, l’azionista è a malapena un altro dei creditori. Le proposte di ulteriore regolamentazione e vigilanza stanno quindi rafforzando il meccanismo che ha protetto i banchieri dalle conseguenze dei propri errori. Se il ministro Tremonti volesse davvero guardare in faccia la radice dei problemi nel settore meno esposto al mercato in tutto l’Occidente, dovrebbe guardare la foto-ricordo del G20 e quella di Jackson Hole, luogo della conferenza dei banchieri centrali. Crosspostes da Giornalettismo
Posted by J.C. Falkenberg at 4:04 PM |
Labels: Banche , Banche Centrali , G20 , giulio tremonti
venerdì, agosto 14, 2009
Crosspost of the day : l'Avviso comune sul credito
Crosspost da Libertiamo.it
- L’accordo fra banche ed associazioni di categoria firmato pochi giorni fa potrebbe essere una buona notizia per le piccole e medie imprese italiane, se fosse applicato rapidamente ed in buona fede. Purtroppo, l’attenzione alla sostanza nel breve periodo lascia aperti due rischi sostanziali di medio e lungo periodo: che questo accordo venga pagato a caro prezzo dal contribuente e che si trasformi nell’ennesimo chiodo nella bara del futuro di una economia libera e prospera.
L’Avviso Comune siglato il 6 di agosto dall’ABI e da una serie di associazioni di categoria fornisce un quadro comune alle banche intenzionate ad estendere in maniera sistematica alla piccole e medie imprese in migliore salute gli strumenti d’intervento che sono molto comuni per le imprese grandi e medio-grandi, cioè il riscadenziamento del rimborso dei debiti per aziende solvibili, ma in temporanea illiquidità.
I requisiti necessari per accedere al programma sono rigorosi, ma non eccessivamente: l’azienda dev’essere stata un pagatore regolare sino al 30 settembre 2008, ossia all’inizio della fase più acuta della crisi. Non viene previsto un aumento delle linee di credito, ma soltanto una loro modifica, spesso vitale: per chi abbia contratto un mutuo od un contratto di leasing e sia in lieve ritardo sui pagamenti si apre la possibilità di posticipare il rimborso delle quote di capitale per un anno, pur continuando a pagare gli interessi sul debito; ancora più rilevante è l’automatica estensione delle anticipazioni su credito, che permette alle aziende con un portafoglio ordini e clienti solidi di poter ottenere il finanziamento del magazzino e del capitale circolante necessario per poter continuare la produzione di beni la cui vendita è spesso già certa.
Il punto saliente e di maggiore efficacia teorica del protocollo è il principio del silenzio-assenso, ossia l’automatismo nell’accesso al programma per le aziende che presentano i requisiti necessari, la cui domanda si riterrà automaticamente accettata trascorso un determinato periodo di tempo.
E’ questa la vera novità di tutto l’accordo e si tratta potenzialmente di uno sviluppo molto positivo nell’accesso al credito per le PMI.
Questi interventi vengono fatti quotidianamente per le aziende di dimensioni medio-grandi, anche se l’impressione è talvolta che le banche decidano con criteri estranei alle valutazioni di profittabilità. Anche la disponibilità a prestare nuovo credito in cambio di aumenti di capitale è parzialmente cosmetica, in quanto si tratta di una pratica assolutamente normale.
Le intenzioni dell’intervento tremontiano sono encomiabili, anche se il metodo è potenzialmente pericoloso. Il sistema bancario italiano è abituato a trattare le piccole e medie imprese in maniera amorfa, come un banco di sardine a cui riservare indiscriminatamente lo stesso trattamento: finanziamenti a pioggia quando va bene, carestia per tutti quando le cose non girano. Poca flessibilità e soprattutto pochissima attenzione a discriminare fra aziende solide ed aziende improvvisate. La solidità patrimoniale è infatti il segnale di un luminoso passato che potrebbe essere dietro le spalle, laddove invece un’azienda nuova ed in forte crescita potrebbe aver bisogno di finanziamenti per un capitale circolante in crescita in ragione del proprio successo e non dei propri fallimenti.
L’accordo è, quindi, giustamente diretto a salvare la “crema” delle aziende italiane PMI ed in questo è diverso rispetto ai soliti programmi di aiuti a pioggia. Mette inoltre sotto pressione le burocrazie bancarie nel proprio punto più debole, la lentezza di risposta verso le imprese non “amiche” e favorite, spingendole in teoria ad un aumento dell’efficienza nella propria attività caratteristica. Il problema fondamentale dell’accordo risiede nel carattere dirigista della sua gestazione e nella scarsa chiarezza del rapporto fra governo e banche. Rimane innanzitutto da capire cosa ci guadagnano le banche dall’adesione a tale protocollo, per il momento pienamente opzionale. Il ministero non ha ancora promesso nulla, ma si profila uno scambio di favori a spese della fiscalità generale, come ha dichiarato lo stesso Tremonti:
“Dal funzionamento dell’accordo dipenderà la decisione del governo di rivedere il meccanismo fiscale delle perdite delle banche,[...]. Se l’accordo funzionerà il governo modificherà il meccanismo fiscale delle perdite. Prima vediamo se l’accordo funziona poi faremo gli sgravi”.
Il primo rischio è quindi che le banche si permettano di accettare la moratoria per chiunque possieda i requisiti formali per accedervi, senza effettuare una sufficiente valutazione. Trascorsi alcuni mesi, il rimborso delle inevitabili perdite sarebbe oggetto di un mercato delle vacche con il Ministero, aggravando il problema procedurale.
Da un governo di centrodestra che si definisce liberale ci si aspetterebbe che non aumentasse l’interferenza statale nell’economia, procedendo inoltre per leggi ed interventi di carattere generale. Tale vincolo è stato rispettato soltanto parzialmente. Questo intervento è stato costruito e propagandato come un intervento quasi personale del ministro e del governo per trovare una soluzione ad hoc, un favore concesso dalle banche e che verrà ripagato con altri favori personali o quasi. Si rischia di dare quindi un terribile esempio: la necessità della continua interferenza governativa nella libertà economica, laddove invece si sarebbe potuto operare senza tale ipoteca, che rischia di compromettere ogni futuro sforzo liberalizzatore del governo verso una struttura economica più equilibrata, libera e di conseguenza efficiente.
Comprendiamo come le sue radici abbiano portato il ministro ad avere un approccio apparentemente pragmatico. Il sistema bancario moderno è un settore ad economia “mista” da sempre, il frutto di un patto faustiano che avvelena da generazioni l’economia di mercato. Il mercato monetario è un monopolio statale, dove la banca centrale decide quanta liquidità erogare e a quale prezzo; il settore bancario è un oligopolio sanzionato dalla classe burocratica e politica, anche dopo la fine della proprietà statale. I banchieri sono ovunque dirigenti ad autonomia limitata da politici e banchieri centrali, che hanno il diritto d’interferire nella gestione bancaria nei minimi dettagli e di ordinare distorsioni nell’allocazione del credito; in cambio, il management bancario ottiene la garanzia esplicita od implicita di un salvataggio e l’autorizzazione a trattare azionisti e clienti alla stregua di un parco buoi.
Dispiace che non si sia colta l’occasione per riformare il settore in senso liberale ed obbligarlo per una volta a camminare con le proprie gambe. Lo sforzo di incentivare comportamenti più razionali da parte degli istituti di credito è meritevole, ma invece di un intervento ad hoc sarebbe stato forse preferibile intervenire sui punti deboli del sistema che possono essere rafforzati senza aumentare l’intrusione della politica nelle banche. Vi sono norme presenti nei tanto vituperati accordi di Basilea 2 e nella recente normativa MiFid che non sono mai state applicate o sono state interpretate in maniera ristretta e favorevole ad equilibri collusivi, sia dal lato del trattamento riservato ai risparmiatori che a quello riservato alle aziende. La rimozione dei vincoli più anacronistici all’emissione di obbligazioni e di carta commerciale, ad esempio, permetterebbe alle aziende italiane di accedere più liberamente al mercato dei capitali, che in questi mesi ha dimostrato di saper fornire abbondante liquidità in alternativa al sistema bancario tradizionale. Soprattutto, una maggiore concorrenza stimolerebbe una maggiore attenzione verso il cliente, sia dal lato del risparmio che da quello dei prestiti. La tendenza all’entrata di banche estere sul mercato italiano ha già portato ad alcune novità, ma l’ostacolo più rilevante è di natura amministrativa: a fronte di una legge relativamente moderna, la prassi delle autorità di regolamentazione restringe drasticamente il campo d’azione per i nuovi operatori, riducendo gli incentivi a rompere l’oligopolio bancario. Inoltre, la politica delle banche italiane è stata troppo spesso quella di sfruttare le normative esistenti per frapporre limiti alle scelte disponibili ai risparmiatori ed ai clienti, boicottando ogni attività volta a responsabilizzare gli investitori. Leggi nate per difendere consumatori poco sofisticati hanno bloccato lo sviluppo del settore, senza per questo costituire una vera protezione per il risparmio o per le aziende. Questo eccesso normativo puramente formale, che garantisce una facile rendita di posizione al sistema bancario, non viene scalfito dai provvedimenti attuali.
Se con questo accordo volevamo normalizzare il settore bancario e lasciarlo finalmente funzionare come ogni altra industria in un’economia di mercato, siamo probabilmente sulla cattiva strada. Se vogliamo continuare ad impiegarlo come l’equivalente economico di un a squadraccia paramilitare, la soluzione italiana è migliore della sua versione USA, ma d’altro canto, abbiamo (tragici) decenni d’esperienza nel settore, al contrario degli americani, nuovi arrivati nel mondo del corporativismo. Non lamentiamoci però se gli italiani decideranno di votare per partiti onestamente socialisti, invece che per una loro imitazione, o se la belva ci sfugge di nuovo di mano: Frankestein, e la vicenda IRI, insegnano che certe creature hanno il brutto vizio di rivoltarsi contro il proprio padrone.
domenica, luglio 19, 2009
Riflessioni mercatiste
Il problema è che siamo abituati a chiamare "mercato" qualcosa che invece vengono manipolate a scopi politici e redistributivi, oppure non sono un mercato se non nel nome.
Il meccanismo di mercato funziona, sempre, ma è necessario che esista un mercato, un'arena dove una pluralità di compratori e venditori può interagire, senza coercizione. Quando osserviamo da vicino i cosiddetti "fallimenti di mercato, non è un caso che si scopra come siano invece frutto di pesanti interventi politici, sussidi e trattamenti di favore che hanno bloccato o distorto il funzionamento del mercato. E adesso, per "correggere" tali difetti, non si cerca di riparare il meccanismo, ma di distorcerlo ulteriormente, con il rischio che si infranga del tutto.
Prendiamo il caso dlela crisi dei mercati finanziari: si accusano la "speculazione" e i titoli tossici, ma chi è che ha sofferto di più? Proprio le istituzioni più sorvegliate e regolate dal governo, che hanno lavorato male, prendendosi rischi assurdi in base ad assunzioni errate. Tanto, sapevano perfettamente che il governo le avrebbe salvate, date le dimensioni e le garanzie implicite della regolamentazione bancaria.
Ricordiamocelo, la prossima volta che un Krugman o un Mucchetti qualsiasi blatereranno d'aumento dell'intervento pubblico: sono i politici ad aver creato, per stupidità, questa bolla. Dar loro ancora più potere garantisce soltanto che il danno sarà intenzionale e non accidentale, come la triste storia dell'economia europea è qui a dimostrare.
Posted by J.C. Falkenberg at 10:27 AM |
Labels: Banche , Regolamentazione , Socialismo , Statalismo
lunedì, luglio 13, 2009
Speculatori più prudenti dei banchieri?
Il rialzo di Borsa degli ultimi mesi ha distolto l’attenzione dalle discussioni sulla riforma europea del settore finanziario. Si tratta di proposte demagogiche, che aggraveranno il problema e che puntano a punire un settore impopolare, ma che si è dimostrato più prudente e sano di quello favorito dai governi
La variegata comunità dei gestori di fondi alternativi, dagli hedge fund a quelli di private equity, non è particolarmente amata e non ha mai fatto nulla per esserlo. Gli eccessi nel consumo sono stati eclatanti e le loro pratiche, sicuramente più aggressive di quelle degli attori tradizionali, li hanno resi i soggetti più impopolari nel panorama finanziario: un ministro tedesco li definì gentilmente “locuste”; l’ultima enciclica papale è stata riassunta da Milano Finanza con un titolo che suonava “La scomunica del Papa sugli hedge“.
DAGLI ALL’UNTORE – La pubblicità negativa li ha resi sicuramente invisi al grande pubblico e li ha trasformati nel capro espiatorio perfetto per la crisi finanziaria in atto. Le conseguenze non si sono fatte attendere: a Febbraio, Francia e Germania hanno cercato di proporre regole draconiane per limitarne l’operatività; la riunione dei ministri del le finanze del G8 di giugno si è appoggiato il cosiddetto Lecce framework; l’Unione Europea sta in questo momento discutendo nuovi obblighi per il settore degli hedge fund, che imporrebbero una serie di obblighi di “trasparenza” che suonano decisamente punitive. Il desiderio della classe politica di punire un settore popolato da arroganti megalomani refrattari ad ogni considerazione d’ordine politico e allo scambio di favori è più che comprensibile, soprattutto perché così facendo è facile deflettere l’ira popolare verso un capro espiatorio che distolga l’attenzione dal proprio pesante coinvolgimento. L’argomento, tuttavia, solleva parecchi dubbi : siamo certi che gli operatori preferiti dal governo, le banche commerciali tradizionali, si siano comportati meglio? Quando si guarda un po’ più da vicino, i colpevoli sono regolarmente gli istituti più vicini a governi e banche centrali, ossia le istituzioni più regolamentate e sorvegliate. Fannie Mae e Freddie Mac erano garantite “implicitamente” dal Governo, AIG , Lehman, IKB e WestLB erano regolamentate minuziosamente o addirittura partecipate da governi.
PIU’ STABILI DELLE BANCHE – Ad un’analisi più attenta, sia il comportamento che la performance degli hedge fund sono stati migliori di quello delle grandi banche. Proprio perché non regolamentati, gli investitori in fondi alternativi ed in generale nel cosiddetto “sistema bancario parallelo” sono stati molto più attenti nella sorveglianza dei dirigenti. I risultati di questa disciplina sono evidenti: gli hedge fund avevano nel 2007 e 2008 una leva finanziaria minore rispetto al settore bancario, mentre le loro performance sono state meno volatili di e le liquidazioni di fondi sono avvenute senza porre problemi a livello di sistema, nonostante la scomparsa di quasi un terzo dell’intera industria: il settore, in aggregato, ha perso il 18% in un anno ed ha visto le masse gestite scendere del 30% ; il settore bancario ha visto la propria capitalizzazione scendere di due terzi nello stesso periodo - e tacciamo delle somme prestate dalla banche centrali per sostituire i finanziamenti privati. Le sicure, affidabili e tranquille istituzioni finanziarie aiutate, finanziate e supervisionate dallo Stato hanno invece ripetuto il copione tradizionale di una crisi bancaria: troppo credito, con l’incoraggiamento delle autorità, seguito da una bolla speculativa e dal conseguente crollo. Questa volta si è resa necessaria un’operazione di salvataggio senza precedenti come dimensioni, ma la dinamica è fin troppo nota. La migliore gestione del rischio da parte dei “selvaggi” hedge fund non dovrebbe stupire: nel mondo degli investimenti alternativi, chi sbaglia paga di tasca propria. In quello bancario, chi sbaglia fa pagare il contribuente, ma si tiene la retribuzione. I cosiddetti hedge fund sono stati definiti “uno schema di compensazione mascherato da asset class”: prima della bolla speculativa e della crisi, la società di gestione intascava il 2 per cento delle masse gestite ed il 20% di ogni profitto. Per poter caricare commissioni di quell’entità, un gestore deve essere ritenuto uno dei migliori nel suo campo , avere un ottimo curriculum e dare forti garanzie di continuità. Anche per questo, i gestori sono solitamente soci nella società di gestione e, soprattutto, buona parte della retribuzione viene investita nei fondi che gestiscono: se sbagliano, pagano sia con buona parte del proprio reddito che con una larga fetta dei propri risparmi. I fondi di private equity hanno strutture di compensazione simili a quelle degli hedge fund, anche se strutturate in maniera lievemente differente e con una minore partecipazione per i dipendenti. L’incentivo a rischiare soltanto in maniera controllata e razionale è quindi forte, al contrario di quanto accade nel settore “tradizionale”, dove gli stipendi sono fissi ed i bonus minori, ma la penalizzazione per il fallimento è molto meno forte. A livello bancario, poi, la contropartita della regolamentazione governativa è il supporto, implicito o esplicito, che viene fornito anche alle banche meno solide. Questo assetto pone un premio sulla disponibilità a rischiare anche oltre il giusto, oltre che sull’acquiescenza ai desideri delle autorità di vigilanza e della classe politica: la gestione del rischio non serve, quando paga Pantalone.
PREMIARE I PEGGIORI – In un mondo ideale, non dovrebbe essere necessario alcun intervento governativo particolare nel settore finanziario: la vicenda IRI, con il panettone di Stato e i disastri nei “settori trategici” , dovrebbe chiarire come affidare alla classe politica il potere d’interferire nelle scelte individuali sia il male minore e non un fatto di per sé positivo. Ogni proposta razionale di riforma del settore finanziario dovrebbe quindi partire dall’idea di estendere il tipo di regolamentazione che ha prodotto il risultato migliore e premiare gli operatori che hanno saputo gestire meglio il rischio, superando la crisi senza ricorrere all’intervento pubblico. Le proposte attuali , invece, vanno esattamente nella direzione opposta: estendono le norme del settore bancario, così ben regolato da generare crisi da generazioni e che ha richiesto interventi per decine di miliardi di euro, ad un settore che, lasciato a se stesso, ha dimostrato di poter sopravvivere ad una crisi drammatica evolvendosi in maniera radicale senza dover chiedere aiuti governativi. Rimane da chiedersi se si tratti di semplice ignoranza da parte della classe politica, oppure dell’ennesimo tentativo di trovare un capro espiatorio, per non perdere potere e non ammettere il fallimento dell’intervento governativo e burocratico nel settore dove forse la lunga mano dello Stato agisce da più tempo e con più intensità. Meglio, molto meglio accusare il “mercatismo”, ideologia sconosciuta nel mondo bancario, dove la commistione fra governo e industria è pressoché totale.
Crossposted from Giornalettismo
Posted by J.C. Falkenberg at 1:22 PM |
Labels: Banche , Banche Centrali , Collettivismo , hedge funds , Liberalismo , speculazione
martedì, maggio 19, 2009
Una speranza per il ritorno del capitalismo nel settore bancario
L'entrata di azionisti forti e determinati potrebbe essere il primo passo per l'eliminazione del vecchio patto diabolico fra dirigenti bancari, burocrati delle banche centrali e politici
|
Posted by J.C. Falkenberg at 6:17 PM |
Labels: Banche , Socialismo
mercoledì, aprile 22, 2009
Le banche "salvate" vanno fatte a spezzatino
UIna delle peggiori "conseguenze inattese" ma ben conosciute dei salvataggi e delle nazionalizzazioni è il danno fatto alle aziende sane: invece di potersi espandere, sostituendo quelel mal gestite o incapaci di ristrutturarsi, si ritrovano a competere con dei concorrenti inefficienti, che sarebbero altrimenti fallite.
Come in Giappone quindici anni fa, il fiume di denaro regalato alle grandi banche ed alle grandi aziende rischia di fare danni enormi al tessuto economico, facendo fallire anche le piccole banche, che invece sono molto spesso sane e prudenti; non tanto grazie a qualche virtù particolare, ma grazie ad una minore una regolamentazione ed una minore tutela: l'agenzia che assicura i depositi, la FDIC, le lascia fallire come una qualsiasi azienda, preoccupandosi soltanto della difesa dei depositanti.
Questa è una delle ragioni ragione per cui persino uno statalista comeil Premio Nobel Stiglitz sostiene lo "speazzatino", ossia la necessità di scindere le grandi banche salvate in puù unità. No so se sai la soluzione giutta, ma è evidente che il semplice regalo di metri cubi di moneta ad alcuni favoriti costituisce parte del problema e non della soluzione.